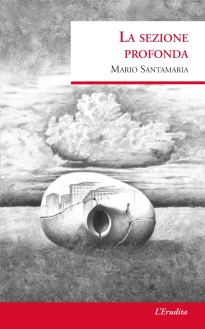(racconto vincitore del Premio Nazionale Roberto Iannilli, edizione 2021)
Chiara era mora e faceva girare le teste. Chiara era finita nei cinquantuno del Piolet. Chiara riusciva a respirare solo in salita, dormiva bene solo accovacciata su una cengia, e sentiva forte la vita solo quando se la giocava ai dadi sulla punta dei polpastrelli. Solo era anche la parola preferita di Chiara. Per lei una cosa era solo o non era. Io invece. Appena dopo i trentacinque avevo già in testa un mocio sale e pepe. Pepe, si fa per dire. E le teste rimanevano fisse. A guardare altrove. Avevo iniziato a scalare tardissimo, dopo decenni di subacquea. La chiamavo verticalità inversa, che faceva fico. Detta così sembrava qualcosa di propedeutico. Di exploit, nomine, premi, nemmeno a parlarne. Ma soprattutto, dopo dieci anni di strizza, mezze chiamate della signora oscura, e un fulmine che mi aveva lasciato sorda per tre mesi, io avevo chiuso. Di alpinismo volevo sentirne parlare sì. Sui social network, però. In televisione, le due o tre volte l’anno in cui Alex mi convinceva ad accenderla. Quell’inverno sognavo già la mia muta nuova. Il tuffo morbido nella verticalità inversa. E questo anche se l’unica volta in cui me l’ero vista davvero brutta era stata a meno quaranta. Metri.
Quindi perché proprio io? Perché Chiara continuava a insistere? Con tutta la gente che sbrodolava per accompagnarla in capo al mondo. Uomini e donne. Perché voleva me per quella parete maledetta?
“La possiamo salire solo così.” Solo. Appunto. E al telefono aveva quella voce lì, quella che conoscevo. Quella che ti lasciava sul palato il sapore ferroso della paura ancora prima di riuscire a rispondere.
“Non lo so. Sto attraversando una fase strana.” Se la prendevo da lontano, magari riuscivo a fare breccia. “Sono completamente disallineata rispetto ai miei desideri. Hai presente?” Il gorgo mugugnante significava che no, non aveva presente. “Quando vuoi essere da qualche parte, ti sforzi e poi finalmente ci sei. Ma appena ci sei ti accorgi che vorresti essere altrove.”
“Hai ripreso con quella robaccia.” Forse ero stata troppo vaga. “Adesso vengo lì e lo prendo a calci in culo.”
Si riferiva alle benzodiazepine. Come con la verticalità inversa, dirlo così faceva più fico. Xanax suonava troppo patologico, infantile quasi. Xanax era la parola che usava Alex. Giovane medico, ex alpinista estremo, guarito, diceva lui, grazie all’autoaiuto. E allo Xanax. Le benzodiazepine gli avevano tenuto a bada l’ansia nel periodo terribile del distacco. Poi, come tutti i tossici era andato a scalare, nel senso di diminuire. Prima con l’alpinismo grazie allo Xanax. Alla fine con lo Xanax grazie alla vita. Il pilotto d’ordinanza te lo propinava con le braccia semiaperte e la calvizie protesa e il mento appena sbarbato da ducetto. Non c’era da meravigliarsi che a Chiara stesse sulle palle. In senso figurato, ovvio.
“Alex non c’entra niente. Non è Alex che decide cosa posso o non posso fare.” Chiara si schiarì la gola sul mio timpano. Andai oltre, fingendo di non aver capito. “È che in questo periodo. Hai visto che succede in Cina?” Magari se la prendevo da lontanissimo. Chissà.
“In Cina succede ogni cinque anni. Non è roba che ci riguarda.” Chiara era una biologa che studiava le cause ecosistemiche delle epidemie. Il che faceva molto più fico della verticalità inversa e delle benzodiazepine. Certo, la mezza idea che mi ero fatta non era vaga, di più. E Chiara evitava l’argomento lavoro come le creste. Troppa esposizione e troppo marciume da gestire. Eppure, avevo imparato che lanciare la palla nel suo campo poteva tornare utile. La scollava per un po’ dalle sue fisse. “E poi che c’entra la Cina. Che fai cambi discorso?” Non stavolta però.
“Hanno messo in quarantena una città intera.”
“Senti, dobbiamo vederci. Al telefono non si può. Ci si capisce solo di persona.” Solo non era semplicemente la sua parola preferita. Solo era il muro fra presente e passato. Era un traverso impossibile da disarrampicare. Dopo solo, indietro non tornavi.
“Senti ma perché proprio io? Ce ne sono cento più forti di me che ti pagherebbero per.”
“Ci vediamo al solito posto. Domani alle sette. Devi portare solo due cose. Qualche idea e la mia socia. La sguattera di Alex lasciala a casa, fai il favore.” Vaffanculo sarebbe stata la risposta giusta. Mandarcela era quello che volevo con ogni cellula. Ma lei tirò dritta, come dopo ogni solo. E io e i miei desideri, era lampante, ci incontravamo di rado e per puro caso ormai. “La scorsa settimana sono stata da Patrizia ed era come sospettavo. Roberto aveva preso appunti.”
“Sei andata a rompere le palle a Patrizia? Io non.”
“Domani. Solito posto.”
Il solito posto era dove mi aveva detto ciao la prima volta. Cinque anni prima. Si era fermata di colpo con la pelle lucida di caldo e le cuffie ancora su. Le aveva calate sorridendo e mi aveva teso una mano nodosa e gentile. Io sono Chiara, aveva buttato lì come fosse normale piantarsi davanti a qualcuno in mezzo a un parco. E tu sembri una Vale, per Valentina, aveva aggiunto. Per riconoscerci erano bastati i polpastrelli d’acciaio che mi rassicuravano il mignolo. Stesso sguardo. Stesse gioie rigate di fatica. Stessa tribù. Solo che lei era la sciamana che interrogava la roccia. Io una inizianda ancora acerba ai primi bivacchi. E non mi chiamavo Valentina, ma da allora era stato Vale. Chiara e Vale, Vale e Chiara. Per un lungo anno di sveglie con le stelle e attacchi all’alba e incoraggiamenti a comando alternato e ritirate e cime rabbiose e abbracci fradici di temporale. Era l’anno in cui Alex ne stava uscendo. L’anno in cui eravamo stati più lontani.
Poi c’era stata la cengia.
“Perché proprio io? Perché insisti?” Eravamo al solito posto. Le nostre voci giganti in quel piccolo teatro romano, seppellito nel cuore verde della villa. Le gradinate sbocconcellate dagli inverni, riconquistate dalle erbacce, firmate dalle adolescenze cittadine. Sotto al palco, stratigrafie di filtri griffati e vetri e lattine e stracci e altri depositi del vento. Sopra al palco, noi e gli stessi brandelli che stavano sotto. Solo più radi e disposti meglio. Come se quassù il grecale avesse composto invece di ammucchiare.
“Guarda gli schizzi.” Chiara dondolava le gambe verso l’orchestra di rifiuti. Stretta nel piumino, mi allungò i fogli e tirò giù un sorso direttamente dal thermos. Uno dei due lampioni aveva dato forfait da mesi e la luce rimasta bastava appena a rischiarare i tratti leggeri di Roberto. “È un settore della parete quasi inesplorato. Un pilastro gigantesco dove c’è un tentativo di Bini, forse di altri. Duecento metri che risalgono agli anni ‘90. Poi niente di niente fino all’intuizione di Roberto e Luca.” Col dito seguiva la linea. L’ipotesi di Roberto. L’eredità che già sentiva sua.
Le restituii i fogli come se scottassero. Presi il thermos e mi versai un po’ del suo tè caramelloso anche se non avevo sete. Anche se non avevo freddo. Il fulmine non mi aveva strappato via solo i suoni. Mi aveva anche lasciato metà corpo insensibile alle temperature estreme. I suoni dopo un po’ erano tornati. Il freddo e il caldo, quelli seri, no.
“Ci andiamo alla fine dell’inverno, quando le sezioni meno solide le tiene insieme il ghiaccio. Finiamo la via in onore di Luca e Roberto. Gliela dedichiamo. La chiamiamo Roccia di Luna, con le parole che iniziano come i due nomi. E ci sta, che tanto bivacchiamo sicuro.” Mi lanciò uno sguardo radioso che le sollevò gli zigomi. “Ti rendi conto di cosa significa? Una cordata di sole donne?” Al telefono avevo capito bene, ma bene a metà. Non si trattava solo della parete, ma proprio della via maledetta. E sugli schizzi, a leggere i commenti di Roberto, insomma. La paura smetteva di essere una sensazione ariosa e diventava solida. Ti si sedeva in braccio. Era bollente. E quel calore sì che lo sentivo.
“Solo così possiamo salirla. Solo alla fine dell’inverno. Solo io e te.” Si rivolse alla nostra platea in decomposizione e alzò il tono. Necessario, dopo tre solo in fila. “L’alpinismo asfittico del centro Italia ha due volti nuovi. E sono donne. Chiara e Vale riescono dove solo in pochi avevano avuto il coraggio di tentare.”
Il solito posto era il nostro posto preferito per due motivi. Lì dentro succedeva quello che succedeva appena l’umanità si assentava un attimo. La natura riempiva le fratture, i solchi, spargeva in giro sé stessa, e poi abbracciava, ingoiava, digeriva gli artefatti. In quel piccolo teatro sbriciolato si metteva in scena il sogno radicale di Chiara. La rimonta del non umano ai danni dell’umano. Non solo però. Stando su quel palco alzavamo lo sguardo e il soffitto di cristallo esplodeva in nuvole di stelle. Due donne a declamare dal luogo che la tragedia classica gli proibiva. A declamare qualunque cosa gli venisse in mente. A progettare l’invasione del paradiso dei maschi. Chiara ne era certa. E il simbolismo di genere la eccitava quasi come l’insurrezione dell’ecosistema. A me invece, il solito posto sembrava un rifugio minimo dove ci illudevamo di controllare gli eventi. Di ottenere qualcosa. Mentre il mondo là fuori se ne fotteva. Un po’ come l’alpinismo. Ma mi nascondevo sotto al mocio e la lasciavo fare. Partecipavo a sprazzi. Come con l’alpinismo ormai.
“Non mi hai ancora risposto.” Le restituii il thermos e ciondolai le gambe a tempo con le sue. Destra, sinistra. Sempre più ampia l’oscillazione. Sempre più lenta. Come quella volta sulla cengia. Smisi all’improvviso e il suo malleolo mi picchiò la tibia. Urlammo insieme. Ridemmo insieme.
“Stai lì con la felpetta e mi chiedi perché io, perché io. È ovvio no? Su quella parete alla roccia penso io. Ma mi serve qualcuno che non muoia assiderato in sosta. Qualcuno che si tiri le parti di misto.”
“Sei una cazzara.” Tirai su le gambe e le incrociai. Incrociai le braccia. Volevo la verità. Ma quale? Ero lì con lei dove volevo essere. La notte prima, mentre pensavo al nostro incontro, avevo abbandonato il corpo ai colpi di Alex. Mi aveva presa anche da dietro? Non ne avevo idea. Eppure ora non vedevo l’ora di andarmene. Volevo la verità ma sapevo anche che avrebbe avuto un prezzo. L’asincronia dei desideri. Ci avrei potuto scrivere un manuale.
“Con l’alpinismo non sono stata fortunata.” Chiara si massaggiò il malleolo. “Ho conosciuto più imprese che persone. Più gente che vuole fare qualcosa con te, che venire con te a fare qualcosa. E con la gente la proprietà commutativa non funziona. Perché le imprese hanno obiettivi ben precisi, come fossero fatturato. Difficoltà. Prestazione. Collezione. Quantità. E allora ti vedi come con Tinder. Per sbrigare le esigenze contingenti. Prima e dopo niente, o poco più. In una strana corsa contro il tempo in cui è proibito sprecarne per attendere, coltivare, nutrire. E se vai a guardare, sei lì per un motivo ben preciso. Perché gli risolvi i passaggi chiave. Perché nell’elenco delle telefonate quelli prima hanno risposto picche. Perché sei quella di bocca buona che certo, figurati se non ti accompagno. Con l’idea fuori moda della corda che lega due biografie e le fonde in un presente allungato comune. Che poi apre ad altro. Che lentamente crea una relazione che sconfina, che si allarga.” Giocherellò col thermos per un po’ e lo posò più in là. “Poi se sei fortunata incontri l’eccezione. Incontri te.” Si strizzò il naso. Passò l’indice sotto un occhio ed espirò. L’esalazione breve a labbra schiuse di quando si emozionava. La morte del prima o la nascita del dopo? Non ero ancora riuscita a capire cosa fosse quel punto Morse, quell’attimo di esitazione. La vidi fissarsi le scarpe che dondolavano di nuovo. Timide. Senza sfiorarmi.
“Sì, sei proprio una cazzara.” L’oscillazione morì a metà. Chiara si girò con lo sguardo grigio delle giornate no. “Ti sei dimenticata tutti quelli che ti si vogliono scopare.” Risi prima io. Poi ridemmo insieme.
“Figurati se mi dimentico i tonni impazziti per quei dieci centimetri di carne umida. Li capisco bene. Talmente bene che mollargli lo zaino carico e tenerli in scia è un attimo.” Tirò su le gambe e le incrociò davanti alle mie. Mi offrì il tè ma rifiutai. Oltre al mocio, anche la mia vescica era sale e pepe ormai. “Sono carini però, dai. Alcuni ti fanno quasi tenerezza. Si impegnano a battersi il petto, diventano anche premurosi. Poi appena si inchiodano sul tiro duro e tu passi, ti guardano come i bambini. Con la virilità appesa. Dicendo brava e pensando troia.”
Sì, era e rimaneva una cazzara, e lo sapeva. Non per la storia dei tonni però. Ma perché il motivo per cui insisteva era un altro. Il motivo era la notte sulla cengia. Quella notte. Su quella cengia. La conoscevo troppo bene. A differenza mia, Chiara ci pensava in continuazione. Chiara conservava le foto di quel corridoio di detriti e terra. Chiara si era quasi dimenticata cos’era successo prima e cosa dopo. Di quella via Chiara ricordava solo la cengia. Solo la notte. A differenza mia.
“Una serata si può chiudere solo sui medi.” La vidi saltare giù e scaldare le articolazioni regalandomi gestacci. Le risposi a tono, tanto non c’era storia. Se non le davi spago, ti martellava e ti martellava e ti martellava. E alla fine ti prendeva per stanchezza.
Il gioco dei medi era un gioco stupido. Era un gioco da maschi che fanno a chi ce l’ha più lungo. E penso le piacesse proprio per quello. Perché era stupido ed era maschio. E se battevi i maschi a un gioco stupido e maschio, era come dire sono tutto quello che sei tu. E poi altro. Molto altro.
Oltre che stupido e maschio, il gioco dei medi era anche semplice. Andavi nella buca di sabbia con lo scivolo e le altalene. Ti infilavi sotto la piramide di rete. Individuavi la maglia che ti piaceva di più. La saggiavi con i medi. E al segnale ti appendevi. Tutto il corpo su due dita. Solo che quando Chiara ti sfidava, lo faceva da vera stronza. Ti lasciava scegliere la maglia e poi si appendeva accanto a te. Tu a sottrarre anche il respiro. Lei con lo zaino carico di sassi.
Faceva la faccia seria. Guardava dritto avanti e ti sbirciava solo per controllare se già soffrivi, quanto soffrivi, come soffrivi. Se non mollavi presto, rimaneva appesa a un solo medio e con l’altro fingeva di punzecchiarti. E rideva la stronza. Rideva.
Ovviamente al gioco dei medi vinceva sempre lei.
“Se nella vita riesci a fare qualcosa che abbia un senso non è perché sei riuscito a mettere a frutto i tuoi talenti, ma i tuoi difetti. Perché hai capito che farci, coi tuoi difetti.” Eravamo alle solite. Lui a dare lezioni. Io e il mocio a sperare nella campanella della ricreazione.
“Tutta questa storia per un giorno di ferie?” In realtà era il nostro anniversario e avevo detto sì a Chiara. Dopo una settimana di no, forse e vediamo. Una settimana in cui avevo inventato di tutto. Consigli di classe. Genitori impazziti. Un ragazzino che mi aveva piantato la matita in una mano. Ci mancava solo una strage modello Columbine per scadere nel ridicolo. Per tenerla buona non avevo saltato nemmeno un allenamento. Ma gli inviti in montagna, quelli. No, guarda, domani non posso. Ho riguardato le previsioni e c’è umidità in ingresso. Troppo vento. Secondo me la perturbazione anticipa. Insomma, lo scusario classico al gran completo. Poi però avevo dovuto cedere. La coincidenza con l’anniversario era ciò che era. Una coincidenza. Non proprio del tutto, diciamo. Forse mi ero anche dimenticata. Un po’. Ma comunque sarei tornata in tempo per la cena e le candele e le carezze e le frasette.
E per il dopocena. Per i colpi. Per l’accoppiamento di rito.
“Un giorno di ferie.” Alex si strinse la base del naso. Più era incazzato più la morsa tremava. Più sembrava una scusa per scaccolarsi. “Il mio talento erano quelle rocce maledette. Ma ho avuto il coraggio di chiudere, per sopravvivere. Per far sopravvivere noi. Il mio difetto? Ero ossessivo, ero compulsivo. Mi sono lasciato ossessionare dallo studio. E la mia compulsione l’ho messa a frutto con i pazienti. Con le cure. E tu? Qual è il tuo difetto?”
Da dove vuoi che inizi? Stavo lì lì per chiederglielo. Ne avevo talmente tanti che a dimenticarli si faceva presto. Se ne avessi messi a frutto anche solo un terzo, avrei svoltato sul serio. Verticalità inversa sulla barriera australiana a giorni alterni e niente più classi di semi analfabeti, niente più presidi. Soprattutto niente più presidi. E invece.
“L’alpinismo è l’unica cosa che non facciamo insieme. Ho solo bisogno di spazio. Di aria.” Perché gli stavo raccontando quella balla cosmica? In realtà non ero nemmeno certa che lo fosse. Sembrava esserlo quando ero con Chiara. Mentre con lui funzionava. Con lui che aveva detto basta, volevo le montagne. Con Chiara che iniziava a vivere dal casello di Carsoli in poi, non vedevo l’ora di appendere tutto al chiodo.
“L’alpinismo.” Ridacchiò come se avessi detto il parrucchiere, la manicure. “Quand’è che inizierai a crescere? Vuoi vedere com’è la vita sulla soglia? Vieni con me. Vieni in corsia. Ti trovo un posto da volontaria. Da ieri abbiamo anche due pazienti col virus cinese. I primi in Italia. Robetta divertente. Del tipo guanti, tuta, mascherina, visore. Un bel nemico sconosciuto. Adrenalina pura a camionate. Vieni, se hai il coraggio.”
“Andiamo a fare un giro al Terminillo. Non starai esagerando?” Provai a raccogliere il mocio. A spingerlo dietro alle orecchie. Ad assumere una posa decisa. Irremovibile.
“Chiara la conosco meglio di te.” In effetti, nei suoi anni tossici avevano anche scalato insieme. Qualche prima invernale assurda sulla est del Piccolo, se non ricordavo male. Nell’ambiente erano tipo Superman e Wonder Woman. E a dire il vero non avevo mai capito come mai fra loro, niente. “Lo so che significa un giro al Terminillo.”
Il suo cellulare iniziò ad agitarsi. Guardò me e la mia posa irremovibile. Poi tornò con gli occhi sugli squilli. Andò avanti e indietro per un po’. E alla fine si arrese. Il mocio domato e la posa guerriera avevano avuto la meglio. “Devo rispondere.”
In realtà era l’ospedale. I due cinesi si erano appena aggravati.
Ovviamente aveva ragione lui. Il giretto si era trasformato in un’odissea di sali e scendi. Ovviamente me l’ero fatta addosso in più di un’occasione. Ovviamente non ero pronta e non lo sarei mai stata. Ovviamente lo sapevo io e lo sapeva anche Chiara. Glielo diceva ogni mio affanno. Ogni picca che andava a vuoto. Ogni bestemmia da prima, ogni grugnito da seconda. Ma la sua follia generosa era una coperta così grande che bastava per entrambe. Devi solo allenarti un po’. Un altro mese con me e non ci ferma nessuno.
Il problema infatti non era che ci fermasse qualcuno. Semmai che ci fermasse qualcosa. Qualcosa di molto brutto, gelido e che io avrei sentito solo a metà. Almeno all’inizio.
Ovviamente arrivai tardi. Al ristorante, alla cena, all’anniversario. Il cameriere mi spinse addosso un’espressione di disgusto e mi indicò il tavolo. Alex stava tagliando le zucchine grigliate a triangoli rettangoli. Le melanzane a quadrati ricavati su lati e ipotenuse. Non li mangiava. Li pitagorava avanti e indietro. Sollevò gli occhi solo quando sentì i miei passi. O forse l’odore. Non avevo avuto il tempo di passare da casa. Avevo il pile sottobraccio e la maglietta che evaporava ancora. Due ramponate fresche fresche mi avevano squarciato i calzoni, senza nessun rispetto per la moda, né per la simmetria. Il mezzo sorriso gli evaporò del tutto proprio sulle ramponate. Mi fece sedere con la faccia nella nebbia e un gesto da borgata ripulita. Lento. Controllato. Poi si alzò e poggiò il tovagliolo sul piatto.
“Ti consiglio la tagliata. Cottura media.”
E se ne andò senza mai voltarsi.
I suoi teoremi vegetali mancavano un po’ di sale. Ma come antipasto, niente da ridire.
Passavano i giorni e il preside insisteva. Che intenzioni hai, era il ritornello. La strofa invece andava dritta al dunque. Tre giorni di assenza in due settimane, e non mi sembri malata. Gli studenti di quinta si lamentano. Dicono che è quasi meglio quando non ci sei. Il supplente almeno non si addormenta. La madre di Ricciardi dice che in classe ti togli le scarpe. Ti massaggi i piedi. Dice che la puzza. La puzza, capisci? E poi c’è il padre della Crisanti. È venuto perfino lo zio della Lopalco. Quando aveva tirato in ballo la prozia di Zangrillo me l’ero perso. Zangrillo l’analfabeta che scriveva famo e dimo nei compiti in classe, che confondeva Rinascimento e Risorgimento? Non ce la potevo fare.
Passavano i giorni e gli orari di Alex diventavano sempre più assurdi. Gli trillava il telefono come a Kruscev durante la crisi dei missili a Cuba. Entrava a casa tirandosi dietro una scia di disinfettanti e un umore giallomarrone. Più o meno lo stesso colore dei marchi che gli lasciava sotto gli occhi la mascherina. In fronte portava scolpito il segno del visore. Apriva le porte con i gomiti, si infilava nella doccia bollente e si insaponava almeno tre volte. Usciva dopo mezz’ora, in una nuvola umida che appannava tutto il palazzo. E niente. Puzzava ancora di corsia, aveva l’umore più livido di prima e il telefono sembrava aspettarlo per riprendere ad annunciare l’apocalisse nucleare. Provavo a intercettarlo mentre rompeva la barriera del suono fra il corridoio e la cucina. Ma dalla sera al ristorante aveva scelto il silenzio. Qui e lì buttava solo qualche monosillabo primitivo. Forse per ricordarsi di non essere sordomuto. Alex non sapeva niente della notte. Della cengia. Non glielo avevo mai raccontato. Per me era un caso chiuso prima ancora che fosse aperto. E per lui sarebbe stata una sofferenza inutile. Eppure. Eppure avevo sempre sospettato che qualcosa avesse intuito. Io ero rimasta identica, immutabile. Lui no. Lui era cambiato. Mi guardava così. Come se. Poi, dalla non-cena per il non-anniversario, il sospetto si era trasformato in una quasi certezza. Mi ero convinta che avesse scoperto la cosa. Che la pensasse ancora aperta. Recente. E che si fosse fatto un film.
Passavano i giorni e le mie balle si stratificavano. Una sull’altra, in attesa delle oscillazioni termiche che le consolidassero. O magari di uno smottamento che facesse finire tutto a valle. Raccontavo balle al preside per allenarmi con Chiara. Le raccontavo ad Alex per riempire i nostri vuoti allergici alla verità. Le raccontavo a Chiara per tenere lontane le montagne. I gradini a due a due sì. Sì le trazioni. Sì le salite col cuore in gola e il culo in pensione da anni che mi punteggiava il sonno di crampi. Sì perfino all’arrampicata di notte, così per abituarsi. Ma le montagne no. Dopo il Terminillo poi, resistevo. Annaffiavo la speranza inutile che fosse lei a desistere. Continuavo a nicchiare, a dire forse, dai vediamo, capiremo. E continuavo a dirlo intendendo no.
Passavano i giorni e virus sparì dai telegiornali. Il pugno di nanometri ora aveva un nome. E sembrava quello di un caccia bombardiere.
Poi successero due cose.
Ero a scuola. Stavo torturando il mocio. Lo arrotolavo intorno agli indici a ciocche e lo strattonavo. Me la prendevo con lui per evitare licenziamento e arresto. Zangrillo inquinava l’aria sferzando i suoi tre neuroni. Silvia, Silvia, biascicava, me pare che è la donna de Manzoni no? De Foscolo? E mi fissava sperando in un tic che confermasse. Allora è de Leopardi. Stavo per mettere fine alle sue sofferenze quando il telefono vibrò nella tasca della giacca. Ne approfittai. Scusate è il preside, mentii. E mi precipitai in corridoio. Finalmente respiravo.
“Sono dentro,” dissi a Chiara, anche se tecnicamente ero fuori.
“Ma hai risposto.”
“Che succede?”
“Stasera andiamo che domani è bello.”
“Non ho visto i modelli. Fammi dare un’occhiata. E poi te l’ho detto.”
“Un sopralluogo. Voglio solo lasciare uno zaino alla base. Ti giuro. La corda nemmeno la porto.”
“Alex. Fammi parlare con.”
“Stasera passo alle sei. Se non sei sotto casa, vado da sola.”
Ovviamente c’ero. E quando alzai gli occhi verso il palazzo, la serranda era giù. Ovviamente. Una notte, avevo balbettato sottovoce mentre nell’aria c’era ancora profumo di lasagna geometrica. Si tratta solo di un sopralluogo. Le do una mano, sennò finisce che ci va da sola. E se poi succede. Qualcosa. Alex aveva scosso la testa, stretto la base del naso a morte e cigolato i denti. Poi si era seduto. Il silenzio monacale avvolto intorno alle spalle, aveva iniziato a mangiare. Gli occhi vuoti. Il dito sul telecomando. In TV c’era il suo ospedale. Nel testo scorrevole i cinesi stavano decapitando la sezione del partito a Wuhan.
Ovviamente eravamo arrivate in piena notte. Camminavamo già da un paio d’ore quando ci fermammo. Ovviamente lei davanti con uno zaino da mille chili. E, altrettanto ovviamente, io dietro col fiatone a contare i passi.
“Hai freddo?” mi chiese.
“Un po’.” Ed era vero. In maglietta, col venticello che si aggiungeva ai meno-non-so-quanto, insomma. Qualcosa sentivo pure io. Anche nella metà sonnolenta.
Il Fondo della Salsa era un posto terribile solo a pensarci. Mezzo nome sapeva di Caraibi. Ma l’altro mezzo ti riportava coi piedi a terra. Anzi sotto. Sole, tepore e orizzonti piani potevi pure dimenticarteli. Il posto in cui ti eri andata a ficcare era la cantina umida di un palazzo mostruoso. Più giù di lì non potevi andare. Più giù di lì c’era solo la sepoltura. Più su invece c’era la parete. Durante i giorni pochi e radi del mio alpinismo eroico mi ci ero tenuta lontana il più a lungo possibile. Poi ci ero finita quasi per caso. A scalare un caminaccio marcio con un pazzoide che pensava di essere la reincarnazione di Preuss. E per sottolineare, confermare o vai a capire che, scalava con un paio di scarponi tedeschi di inizio secolo. Peccato che Preuss fosse austriaco. Fatto sta che ci eravamo calati al terzo tiro e avevo giurato di non tornarci mai più. Meno che mai d’inverno. Appunto.
Chiara si era fermata e fissava qualcosa in alto. Io fissavo in basso, mi tenevo le ginocchia e cercavo di non vomitare il cuore. Mi pulsava nelle tempie, nei timpani. Mi pulsava ovunque. Più di quando l’elenco era finito e mi toccava sentire Zangrillo che massacrava i classici. Appena riuscii a sollevare la frontale capii meglio il silenzio di Chiara. Capii meglio anche la mia decisione, quel giorno con la reincarnazione di Preuss. E desiderai con tutta me stessa un’ora di Zangrillo che interpretava Pavese. Il pilastro su cui si arrampicava il sogno di Roberto sgomitava con i prati verticali e si spegneva nel fondo di una nuvola. Chiara lo scrutava con il mento proteso, le labbra schiuse di meraviglia. Nel fascio della frontale capivo l’eccitazione. Vedevo le sue pupille disegnare la linea, immaginare le soste. E alla fine quel soffio leggero verso l’ignoto là dove il cielo ingoiava la roccia. Si tolse il berretto per rifarsi la coda e per la prima volta la vidi. Solo per un attimo, ma era lì. L’ombra nera che di solito riempiva il mio specchio le aveva macchiato il viso da copertina. Lo aveva deformato. Ed era svanita nell’aria odorosa.
“E tu hai paura,” Le dissi.
“Un po’.”
Chiara era la nostra metà bianca di freddo con una punta nera di paura al centro. Io, la metà nera di paura con al centro una punta bianca di freddo. Sulla carta io e Chiara eravamo una coppia da manuale. La cordata perfetta. Ma proprio per quello non saremmo mai riuscite a esserlo.
Ci volle un’ora per scavare due buche nella neve. Ovviamente Chiara scavò la sua in un niente. Ovviamente mi si avvicinò gradassa e scavò tre quarti della mia mentre io arrancavo col quarto rimanente. Prima di infilarsi nel sacco mi disse solo sei sicura. Batté il palmo sul tappetino. In due si sta più caldi. In due la notte passa prima. Due metà fanno un intero, anche un’umanista poteva arrivarci. Pensai ad Alex. Pensai alla cengia. Mi mancava Alex. Mi mancava anche la cengia?
“Buonanotte,” le dissi. E spensi la frontale.
All’alba la trovai a fissare la parete. Lo zaino col materiale era sparito. Era già salita fino alla base del pilastro e riscesa, ovviamente. E lo studiava, il pilastro. Con gli occhi flessi e le dita in scala. Immaginava, moltiplicava i tiri, sentiva i tempi e la fatica che le scorrevano dentro, i passi duri, l’esposizione. E stava lì, dritta come un fuso. Più che da una truna, sembrava appena uscita dalla spa. Io invece. Uscii carponi dal sacco a pelo e mi trascinai fino a lei con le ossa accartocciate intorno ai dolori. Sentivo più dolori che ossa, in realtà. Dovevo pisciare ed ero stanca morta.
“È come immaginavo,” mi disse.
Sì pure io, pensai. Anzi peggio. E iniziai a districare il mocio.
“La neve quasi non c’è.” Indicava la parete che saliva, saliva e non finiva più. Un tendone tetro e cattivo che ogni tanto si scrollava di dosso rivoli bianchi, fiati di gelo, ruggiti lontani. L’inverno assente, diceva lei. L’anno giusto. Giocava tutto a nostro favore. Come no, perfino i ricci mi si erano rattrappiti a guardare lì dentro. A percorrere quel rivolo di pazzia che risaliva il pilastro e chissà dove usciva.
Io vedevo problemi. Chiara vedeva solo soluzioni. Solo, ovviamente. Io lo ying e lei lo yang. O era il contrario?
Poi fu la volta del conflitto. La seconda cosa che successe fu il conflitto. Sul confine fra sì e no, che tutti pensano sia forse e invece è dolore e asincronia e desideri che si calpestano. Un sì strapiombante come ogni parete sconosciuta. Un no profondo e buio come una grotta sottomarina. Ed è proprio in acqua che iniziarono le ostilità. In piscina, mentre facevo fiato dando tregua alle mie ginocchia vare. Ufficialmente. In realtà passavo più tempo a spannare gli occhialetti che a sbracciare. La mano che diede inizio a tutto mi bloccò la caviglia a fine vasca. Avevo appena eseguito una capriola che nemmeno la Pellegrini e non capivo. Riemersi inspirando cloro e lei era lì. Pensai subito a effetti allucinogeni di cui non sapevo. Avevo imparato a nuotare prima che a camminare e sniffare cloro, no, quello mi mancava.
“Abbiamo solo domani per andare.” Niente allucinazioni. Era sul serio Chiara. In mutande e reggiseno, con mezza piscina con la mascella a terra. Il bagnino di turno non sapeva che fare. Se la cacciava, finiva pure lo spettacolo. E stava lì che tentennava. “Ho pagato un ingresso, ma il costume saranno dieci anni che non ce l’ho. Dai sbrigati.”
“Andare dove?” Lascia, faccio io, mi aveva detto. Mi frizionava i capelli mentre mi rivestivo. Il suo corpo si agitava lì accanto e mi inondava. Frangenti di elettricità buona che sapeva di benzodiazepine mi si schiantavano sulla pelle.
“Ti sei incantata. Dai che.”
“Dove?”
“Fidati.” Mi poggiò la mano arcuata sulla guancia, senza esitare. Poi si rese conto. La sollevò e socchiuse gli occhi. I denti le divorarono il labbro superiore. “Scusa. Davvero.”
“Non scusarti.” Anche se aveva fatto bene a scusarsi. Era giusto che si scusasse. Il conflitto si era animato. Il sì e il no avevano esploso i primi colpi.
Il marciapiede era infestato dal viavai. Io e Chiara, le uniche donne che non risuonavano sull’asfalto. Scivolavamo anonime fra passi e falcate e corpi infagottati in un silenzio strano. Un silenzio schiacciato dalle chiacchiere degli altri. Dai clacson. Da sciami di scooter e macchinette smarmittate. Dalla frenata del SUV da transiberiana che ci scaricò davanti una tipa impellicciata.
“Stronze!” ci gridò da dietro la mascherina, borsetta al gomito e stiletto tattico. “Non lo sapete che c’è il virus.” E schizzò via scansandoci.
Chiara sollevò il colletto della giacca e tirò dritta senza scomporsi.
“Ma l’hai sentita quella?” le dissi. “La gente non sta bene.”
Visto da dove era scesa la tipa, mi sarei aspettata il comizio ecologista. Tipo, se solo sapesse che il suo SUV del cazzo, e le emissioni, e l’energia, e le foreste, se solo i neuroni bruciati dalla permanente glielo permettessero, chiaro. Stronza, come no, nello specchio lo dovrebbe urlare. E invece niente. Chiara camminava e guardava in terra. Respirava lenta. Camminava. Sembrava aspettasse. “Che giorno è domani?”
Porca. Cazzo. Zangrillo maledetto. Che non c’entrava niente, ma qualche fischio nelle orecchie male non gli faceva. Mi bloccai in pieno oceano di passi, lasciando che mi punissero spallate, spinte impazienti. Mi ero dimenticata pure questo. Dopo l’anniversario, dopo sanvalentino con la lettera minuscola. Avevo un’allergia alle ricorrenze. Ce l’avevo per forza. La raggiunsi correndo. “Lo so che giorno è domani. Lo so sì.”
Mi guardò e sorrise. Mi prese sottobraccio e mi appoggiò la tempia su una spalla. Sentivo oscillare la fossetta morbida dove nasce la concentrazione. Un punto debole offerto senza remore ai miei dubbi. Il conflitto stava per subire la prima escalation. “E allora sai che mi devi un regalo.”
Sospirai di sollievo, sperando che là fuori non si fosse sentito forte come dentro. “Quello che vuoi. Ma che fretta c’era. Oggi è ancora oggi.”
“Mi porti a scalare.”
Le mie suole si incollarono di nuovo al marciapiede. L’energumeno che mi caracollò addosso fu l’unico che sentii veramente. Gli altri urti della fiumana mi arrivarono attutiti come fossero gradi celsius.
Lo strattone fermò anche Chiara. “Quello che vuoi. L’hai detto tu.”
“Lo sai che. Devo vedere il meteo. E poi Alex. Devo almeno dirgli. E poi dove? Dove vuoi andare?” Bastò Alex, e Chiara sfilò il braccio da sotto al mio. Mentre balbettavo le domande mi guardava ruvida. Con gli occhi che riservava alla roccia quando la roccia tentava di respingerla. “Te l’ho detto. Le montagne in questi mesi.”
“È il mio compleanno. Non ti chiedo mai niente.” Si infilò le mani in tasca e scrollò le spalle. “Ora ti chiedo due notti.” Espirò quel punto Morse breve e doloroso, che sembrava passarmi la palla. E sperai che la smettesse. Che smettesse di colarmi addosso la lava dei suoi sguardi. Di cercarmi dentro dove c’erano solo montagne giganti spazzate sotto i tappeti. Ma non smise. E fra il sì e il no esordì la carneficina.
E vinse il no, contro i silenzi aggressivi di Alex. E poi se succede. Qualcosa. E vinse il sì agli assalti di Chiara. Al compleanno ribaltato in cui era lei a fare una sorpresa a me. Così, tirando le somme, stavo al punto di prima. Sì e no a scambiarsi solo di posto.
Al preside dissi che avevo bisogno di tempo. Il ministro aveva appena detto che si sarebbe andato a riprendere gli italiani sulla Diamond Princess. E io. Io che? Io volevo preparare una lezione coi fiocchi per i ragazzi. Sì, coi fiocchi. Roba innovativa. Relazioni diplomatiche. Storia contemporanea. Attualità. E mi ci volevano almeno un paio di giorni per affinare il progetto. Già.
In soldoni, un mucchio di cazzate.
Fra Alex, senza sapere cosa volesse Alex, e Chiara trovai una mediazione. La notte sarebbe stata una. In pratica, la pianura becera che non è né mare, né montagna. Che non è sì, non è no, ma non sa nemmeno essere forse.
Capii dov’era diretta Chiara quando tirò dritta dopo il traforo. Quando oltrepassò la luna che scolpiva il Paretone. Evitai di parlarne, feci finta di non capire. Di non sentire il nastro che si riavvolgeva. Di non sentire la cengia e la sua eco lungo gli anni.
A Prati di Tivo mi indicò la nord del Piccolo e iniziò a galoppare. La neve cigolava il gemito del rigelo. Le mie ginocchia, quello meno glorioso della seconda età. Lei andava, io seguivo. Lei sempre più lontana, io sempre più lenta. Alla base di Iskra aveva preparato tutto e mi disse qui tocca te.
“Solo tu ci puoi portare su.”
Mi guardai intorno. La notte stellata stava stesa a guardarci. Il vento nascosto fra gli alberi era d’accordo con me. “Tu sei matta in posti che non conosco.”
Ma i miei argomenti non avevano speranza di scalfire i solo di ghiaccio e calcare rigato. La sequenza di incitamenti. Di lodi fasulle. Partii convinta di essere con la persona giusta nel posto sbagliato. E un tiro dopo l’altro quella convinzione divenne più solida del rivolo bianchiccio a cui stavo appesa. Sognavo gli asciugamani squadrati di Alex, le sue posate ortogonali. Sognavo un bel consiglio di classe. Sognavo perfino Zangrillo che faceva collegamenti fra Rivoluzione Francese e Illuminismo. Appena fuori dal diedro dissi basta. Ero solo indecisa se stessero peggio i polpacci, gli avambracci o le chiappe strette per non farmela addosso. Basta era l’unica parola a cui riuscissi a pensare. Basta, che già sapeva di doppie, di luce in fondo al tunnel. Di ritorno indenne. Che sapeva dei colori insanguinati dell’alba. Della notte che andandosene si raccomandava. Tornatevene a casa, sussurrava. Ma chi ve lo fa fare. Ci sono la scuola, l’università, Alex, Zangrillo. Ci sono loro che vi aspettano.
“Adesso però tocca a me.” Chiara fissò una picca allo zaino e mi indicò il traverso. Mi ero illusa. Speravo che la mia performance da storpia l’avrebbe convinta a mollare. Ma non fu nemmeno necessario che infilasse due o tre solo uno dietro l’altro. Era il suo compleanno. Era il modo in cui voleva prepararsi. E lassù fra la Prima e la Seconda Spalla c’era la cengia. Io? Io mi nascondevo sotto al mocio in ebollizione e la lasciavo fare. La seguivo. Ero di nuovo in piena asincronia, ma forse un po’ meno. Alle brutte avevo le benzodiazepine a portata.
La trovai appesa alla seconda scaletta del Ventricini che batteva i guanti. Guardava le pieghe e le placche e le lame. Ripassava movimenti che sapeva a memoria. Danze estive che era capace di ripetere bendata. La raggiunsi stremata che il cielo era già azzurro denso, palpabile. Stava appoggiato lassù, dove non riuscivi a vedere. Era il rimpiazzo della notte, e anche lui sussurrava andatevene. Andatevene.
“Quella facile, ti prego. Sono morta.” Le abbracciai la vita, le chinai la testa sul collo. Il casco fra noi, le ondeggiava sul mento. La sentii rigida, i muscoli perplessi. Realizzai solo in quel momento. Il gesto, le pressioni, il significato. Mi tirai indietro e il mio moschettone scivolò sul piolo di ferro.
“Tranquilla. Ti tiro su io.” Sì allacciò le scarpette, si infilò lo zaino e fece per svitare la ghiera. Si fermò. Si voltò e mi accarezzò il naso con il polpastrello già gelido. Scese lenta. Mi sfiorò la bocca. Volevo fermarla. Dovevo fermarla. Sapevo di doverla fermare. Chiara ingoiò a vuoto, si chinò e appoggiò le sue labbra tiepide sulle mie. Un secondo di schiuma spumeggiante che riempì tutti i vuoti del mio spirito crivellato. Un secondo di cessate il fuoco, durante il quale sì e no si compressero in una risposta che non esisteva. Un secondo ed era già scappata via. Un secondo e mi chiedeva corda, corda, corda.
La nicchia della prima sosta era intasata di neve. Tenere i piedi all’asciutto, impossibile. Chiara aveva addosso il piumino e tremava.
“Ti odio.” Scuoteva la testa. Sorrideva. Mi guardava il pile che stavo slacciando dalla vita. Il pile che mi ero tolta appena le corde erano andate in tensione.
Sulle labbra avevo ancora il sapore delle sue e non sapevo che fare. Dovevo dire qualcosa? Fare finta di niente? Accennare con uno sguardo? E accennare a cosa? Dovevo toglierle i guanti e infilarle le mani sotto le mie ascelle roventi? Dirle basta scendiamo, fare l’offesa, perché a casa avevo un compagno ufficiale? Un uomo? Perché io non ero. Insomma. Nemmeno al liceo avevo mai.
Mentre io nutrivo l’asincronia, Chiara era già passata in modalità verticale. La prendevo in giro da sempre sul suo tasto on-off. In genere succedeva alla base della via. Altre volte sotto al primo tiro impegnativo. La parte orizzontale del suo cervello si spegneva e l’altra prendeva il sopravvento. Glielo leggevi negli occhi. Il verde diventava liquido e il nero si dilatava spingendo i petali di girasole ai margini. Glielo leggevi nei gesti. Aggrovigliava i polsi in una spirale e li sollevava sopra la testa. Poi iniziava a oscillare cercando un ritmo, diceva così. Un ritmo che poi riusciva a seguire scalando sul tiro successivo.
Quando vidi i polsi intrecciati sentii il primo brivido. E avrei pagato perché fosse di freddo. Niente spigolo da aggirare. Niente quinto rilassante. Avrebbe tirato dritto nel diedro. E così fece.
Rinsaccò il piumino in una retina, tolse i guanti e appese tutto all’imbrago, sgranchì le dita e partì. Chiodi lungo il diedro. Chiodo sotto il tetto. Chiodo sopra il tetto. La teoria la sapevo anche io. La pratica era un’altra storia. Che sottozero passava in un attimo dal realismo all’epica. Ma Chiara era Chiara. Chiara non era Penelope, non era Elena. Chiara era Diana, la dea della caccia.
Sotto al tetto disse solo freddina, e intendeva la roccia. Rinviò il primo chiodo e iniziò a schiaffeggiarsi le mani sulle cosce una per volta. Ci soffiava dentro. Esitava. Non l’avevo mai vista tentennare così. C’era ancora il suo ritmo nei movimenti. Ma le battute trascorrevano rapide una dopo l’altra. Tutte uguali, in quella pausa eterna. Sotto il casco il mocio iniziò a prudere. La mia testa andava a fuoco mentre le sue dita si ghiacciavano. Ying e yang. L’armonia del creato.
Armonia un cazzo. Sapevo che non si sarebbe mai fatta bloccare. Sapevo che avrebbe proseguito o si sarebbe fatta calare, gettando la spugna. Scansai la prima goccia di sudore dalla fronte e aspettai. Aspettai. Aspettai.
Un paio di schiaffi più tardi mormorò il solito vado distratto, spostò i piedi e danzò come solo Chiara sapeva danzare. Disse chiodo, alé, quando rinviò sopra il tetto. E solo in quel momento sentii di nuovo le labbra elettriche. Respirai. A fondo. Fuori da una lunga apnea che assomigliava un po’ alla mia vita. Rilassai le spalle e diedi corda. Pensai a Chiara lassù, invisibile. Alla sua melodia di gesti. Alla sua gioia, a caccia di pieghe e rivoli e incastri e scaglie. E diedi corda. Pensai perfino al disgraziato che mi sostituiva a scuola, e diedi corda. Pensai a Zangrillo e Lopalco che lo bullizzavano. E diedi corda.
Poi un monosillabo echeggiò nella valle. Le corde si tesero e saltò via la prima protezione. Saltò la seconda e vidi l’ombra che precipitava. Dietro, il cielo azzurro, carnoso, indifferente. Pensai chiodo. Chiodo. Chiodo. Pregai il dio di metallo che l’aveva forgiato. Pregai il martello umano che l’aveva infisso. Pregai e schizzai verso l’alto. Chiara si schiantò di sbieco un paio di metri sopra la mia testa.
Ci guardammo con l’adrenalina impazzita che ci ronzava nelle orecchie. Appesa all’imbrago, Chiara respirava a fatica. Il colpo, mi dissi. Il colpo. Si teneva una mano, e mi guardava. I suoi occhi dicevano ti prego, no. Ti prego. Ti prego. Se la guardò e la vidi sospirare. Mi mostrò le dita solcate. Il sangue che colava fino al polso.
“Si è rotta. Porca troia. Via i piedi, e la scaglia del cazzo si è rotta. Ora ci caliamo e mi dai lo scotch.” Nello sguardo aveva di nuovo la luce liquida, la spinta verso il sentiero di caccia.
“Ora ci caliamo e ce ne andiamo a casa. Tu sei malata.” La mia voce iniziò a vibrare. Stavo sudando. Una paura bollente mi abbracciava il tronco. Avevo il palato che sapeva di ruggine, le braccia che mi tremavano. Il pugno stretto ancora intorno alle corde.
Chiara provò a raddrizzarsi. “Ti prego, non puoi. Non.” Un urlo le ruppe in bocca i pensieri. La caviglia destra si era già gonfiata. Si accasciò, mani e ginocchia contro la parete. Gli occhi chiusi. Il casco a picchiare contro la roccia, a tempo con il ritmo che le si spegneva dentro. Rimasi in silenzio. Avevo ancora voglia di prenderla a schiaffi ma capivo il suo dolore. Non solo quello alla caviglia.
I giochi erano finiti. E chissà per quanto.
Infilammo il piede a forza nello scarpone e iniziammo la terza ordalia. Cinque ore di mezze calate, mezzi paranchi, saltelli faccia a monte su un solo rampone. Cinque ore di silenzi che non avevo intenzione di fratturare con le solite solfe. Succede. Fa parte del gioco. Quando parti da casa lo sai. Non è rotta vedrai. Cinque ore in cui pensai più volte a quel chiodo. Lo vedevo saltare via. Vedevo Chiara schiantarmisi accanto. Sentivo un ferro rovente infilzato dentro, che premeva, premeva. Sentivo la mia metà addormentata svegliarsi e gridare da ogni centimetro, da ogni poro, da ogni cellula. Cinque ore di requiem definitivo per il mio alpinismo. Finalmente avevo trovato una ragione plausibile. Chiara o non Chiara. Cinque ore in cui provai a dire elicottero un paio di volte e lei nemmeno rispose. Continuò a grugnire, a soffrire, a sforzarsi come una lupa zoppa. Si fermò solo una volta. A guardare il Bonacossa. Il rivolo bianco che portava alla cengia. Quella cengia. Si strappò un paio di lacrime dagli occhi, arricciò il labbro superiore e riprese a saltellare giù per il pendio.
Cinque ore in cui volevo abbracciarla. Volevo prestarle la mia caviglia. Prendermi metà del suo dolore. Piantarle una piccozza nella schiena. Romperle sul serio qualcosa per costringerla a casa. Per interrompere la sua battuta, in cui l’unica preda era lei stessa. Cinque ore in cui pensavo ad Alex. In cui desideravo ciò che eravamo. La nostra casa. La nostra vita. Ma appena avvicinavo la pancia ai pensieri sentivo l’aria pesante. Sentivo l’asincronia che accelerava fuori tempo.
“Guarda non è rotta.” Mi disse in macchina, muovendola a malapena. Come una bambina con la bambola claudicante che si accorge che sì, non è rotta. Non è rotta. “Vedrai che prima della fine dell’inverno.” Strinse la busta piena di neve e la calò sulla caviglia. “Ho solo bisogno di qualche giorno di riposo.”
Solo. Come no. E pregai anche il dio dei giorni perché corressero via veloci verso l’equinozio.
La caviglia non era rotta. Chiara appoggiò di nuovo il piede mentre la Lombardia diventava rossa a metà. A Vò Euganeo testavano a tappeto e lei già zoppicava in giro. In ogni messaggio c’erano mezzi passi felici e la fine dell’inverno ancora lontana. Io tremavo solo all’idea che ricominciasse. Alex invece taceva. Dall’incidente aveva interrotto anche i mugugni. Strizzava la base del naso a morte e accendeva il televisore appena gli rivolgevo la parola.
Milano non si fermava. C’erano gli spritz contro la paura. Poi ricoverarono Sepulveda a Oviedo con i primi sintomi. Chiamai Chiara perché Sepulveda, Sepulveda no. Mi disse che voleva riprendere a camminare all’aperto. Se la aiutavo. Cercai di capire cosa ne pensasse Alex. Era una mia amica. Stava male. Non potevo dirle di no. Alex si strizzò il naso e accese il televisore. Quando tornai dalla camminata trovai un foglio appeso al frigo. Meglio stare in spazi separati, diceva. In ospedale sono troppo esposto. Già si parla di asintomatici contagiosi. Non voglio farti del male. Se hai bisogno di qualcosa, chiama Chiara. Alex si era trasferito nella stanza del nostro bambino mai nato. E la porta era chiusa.
Seduta sul tavolo della cucina con il foglio in mano, oscillai le gambe. Come sul palco nella villa. Come sulla nostra cengia. La cengia che aveva saldato i nostri corpi e ci aveva separate per sempre. Ci arrivammo stanche morte, sulla cengia. A metà di uno di quei concatenamenti che in molti erano capaci di immaginare. Ma che solo Chiara portava termine. Il bivacco non era previsto. Ovviamente ero stata io a rallentarla. E la notte di bonaccia era iniziata calda. Avevamo i teli termici. Avevamo i nostri corpi. Il resto successe così, come succedono le cose che succedono. La temperatura andò giù. Iniziammo a tremare. Prima lei, poi io mezz’ora più tardi. Chiara che era più alta, risoluta, senza vergogna prese l’iniziativa. Si stese a cucchiaio dietro di me. Unimmo i teli e mi abbracciò. Iniziammo a sparare idiozie fra i denti che schioccavano. La mia metà normale si scaldò per prima. Mezz’ora più tardi mi accorsi del ventre bollente di Chiara. Dei suoi seni schiacciati sulle scapole. Del suo respiro profondo e profumato sul collo. E non capivo. Non capivo come mai non mi sentissi a disagio. Mi voltai sperando che fosse riuscita ad addormentarsi ma non era così. Mi guardava. Sapevo che mi guardava. Che anche lei cercava di capire. Poi per la prima volta sentii quel suo alito breve, quel punto Morse sussurrato che mi sembrò echeggiare come una diga che si sfonda.
La notte fuggì via fra carezze, baci e silenzi di piacere e scoperta. Due corpi stesi al centro del mondo e nient’altro. Il resto disciolto là fuori nel buio.
Il sole ci sorprese come un guardone alla finestra del nostro pianeta privato. Ci osservammo con gli occhi degli stranieri. Ci staccammo. Ci coprimmo di imbarazzo. Poi seppellimmo l’imbarazzo sotto la routine di quando sei sulla via del ritorno. Non c’era bisogno delle parole. Non potevamo scalare più di quello che avevamo scalato ed era ora di scendere. Chissà fino a dove.
Alla fine arrivò la diagnosi. Sepulveda aveva il virus. Temevamo che il vecchio non avrebbe più letto romanzi d’amore. E nel frattempo imparammo una nuova parola. Pandemia. Solo Chiara sapeva già di cosa si trattasse. E solo lei sembrava fregarsene. Riprese ad allenarsi con le gambe, come diceva lei. Mi chiese di darle una mano, di tirarmela dietro. Ma era una balla. Anche dopo settimane di fermo, una ventina di minuti e mi doppiava. Provai a comunicare con Alex. A sentire cosa ne pensasse. Feci scivolare un foglio sotto la porta. Per metterlo a suo agio usai lo stesso blocco, le stesse righe, lo stesso stampatello. Quel pomeriggio mi arrivò un messaggio. I tuoi allenamenti non sono affari miei. La situazione qui si fa grave. Dormo da un collega. La porta del bambino mai nato l’aveva lasciata aperta.
Il preside ci riunì. Chiudevano le scuole. Tutte. Ma si continuava a insegnare da casa. Zangrillo esultò come nemmeno allo stadio. Fiero di sé stesso sfoderò una citazione e la attualizzò. Veni, vidi, virus. La classe lo guardava come se ce l’avesse sul serio. L’ultima campanella suonò insieme alla chiamata di Chiara. Tirava di nuovo in ballo la via maledetta. Infilava i suoi solo, solo uno appresso all’altro. Appena scalda. Dopo le valanghe. Preparati, perché si vive un solo giorno. Il resto è memoria o immaginazione. Tirai in ballo Alex che non ballava più già da un po’, ma lei non lo sapeva. Non posso, non ce la faccio, c’è la didattica a distanza. Poi provai con la roba pietosa. Ho pianto, il giorno dell’incidente. Ho fatto pace con la morte del mio alpinismo. E mi accorsi quasi subito che tirando in ballo l’incidente, forse. Sì, insomma. Poteva sembrare che dicessi una cosa per intenderne un’altra. Mi disse non preoccuparti. So che Alex ha bisogno di te. So che i tuoi studenti hanno bisogno di te. Appena ci sono le condizioni vado da sola. Dove arrivo mi calo. Sarà comunque la più grande avventura di sempre.
Trascorsero giorni sospesi. Giorni in cui pensavo alla cengia. Giorni in cui rivedevo l’incidente. Giorni in cui iniziarono a morire i Mario Rossi intubati. Giorni in cui anche i medici dei Mario Rossi finivano in rianimazione. Giorni in cui la morte cantava per le strade con la voce delle ambulanze. Giorni in cui sentivo una sirena ogni volta che pensavo a Chiara da sola con il mostro di pietra.
Poi una sera arrivò il messaggio che mi strappò via una decina di anni. Ingoiai Xanax sufficiente a tranquillizzare l’intero isolato. Giorni di bello, diceva. Vado domani.
Gli anni me li restituì Conte un’ora più tardi. Chiuditi sesamo, che in inglese si diceva lockdown. L’Italia era zona rossa. La regola era io resto a casa. Chiara era salva.
La mattina dopo i siti di montagna uscirono con un titolo urlato. Un boato aveva svegliato i cittadini di Castelli poco dopo l’alba. La nuvola fredda della valanga era quasi arrivata alle porte del paese. Lassù dalle mille teste del mostro, qualcosa si era staccato. Qualcosa di grosso.
Presi il telefono e scrissi a Chiara. Hai sentito? Sì, rispose. Devo vederti, aggiunsi io. Ora. Subito. Solo di persona ci si capisce.
La aspettai al solito posto facendo la spola fra il palco e i giochi dei bambini. Scavando la trincea come Willy il Coyote. Rimuovendo uno strato dopo l’altro. Con le mie due metà che si accapigliavano. Per il freddo però. Stavolta solo per il freddo. E per l’umidità. E per la puzza di piscia. La meravigliosa puzza di piscia che mentre aspettavo diventava odore di primavera. La primavera che avrei visto e annusato di nuovo con lei perché. Perché. Perché a Conte e al suo dipiciemme-non-so-che-numero dovevano fargli una statua.
Alla fine la vidi, o forse era l’inizio. La vidi, un’ombra lunga nel sole appena sveglio. La vidi e le corsi incontro come nei film stupidi montati apposta per farti piangere. Come Aleksèj che trova Anna ancora sulla banchina perché lo Zar ha fermato tutti i treni di Russia. E la colpii. Forte, con una spalla sulla clavicola. Indietreggiai per scusarmi e le pestai il piede. Quello dell’incidente, ovviamente.
Chiara tese un braccio e mi tenne a distanza. Rideva, si lamentava. “Ho capito,” disse rimettendo giù il piede. “Ho capito.”
“E invece no. Non hai capito.” Gesticolavo avanzando di un passo. Gesticolavo indietreggiando di un passo. Uno per il sì, uno per il no. “Il messaggio. Stavo morendo e poi. Se andavi e invece. Hai visto la valanga? Hai sentito della valanga?”
“Vieni qui.” Ma non aspettò che andassi lì. Mi venne incontro come faceva lei quando aveva deciso. E in un soffio mi riportò lassù sulla cengia. Stanca, felice, esattamente nel posto dove volevo essere. Mi spinse dentro l’alito caldo della vita. Mi posò sui denti una gioia umida che sapeva di cocco. La abbracciai e sentii il suo corpo cambiare, modificarsi. I suoi pieni dentro i miei vuoti. Il suo freddo scambiarsi di posto con la mia paura. E quando sollevò le labbra dalle mie capii.
Quel breve respiro di meraviglia a labbra dischiuse, il suo punto Morse. Capii cosa significava. Era la sosta in cui cedi il comando. Era il punto e a capo del racconto di due vite che si attorcigliano. Come i suoi polsi prima del tiro chiave. Ti sento, ti vedo, ti ascolto. Tutto stretto nel ricciolo di condensa che veleggiava verso l’azzurro.
Mi accarezzò il mocio. Spinse una ciocca dietro l’orecchio e il mocio reagì scontroso. La ciocca tornò dove era. Sorrise e appoggiò la fronte sulla mia.
“Voglio sapere come ti chiami,” sussurrò. “Come ti chiami veramente.”